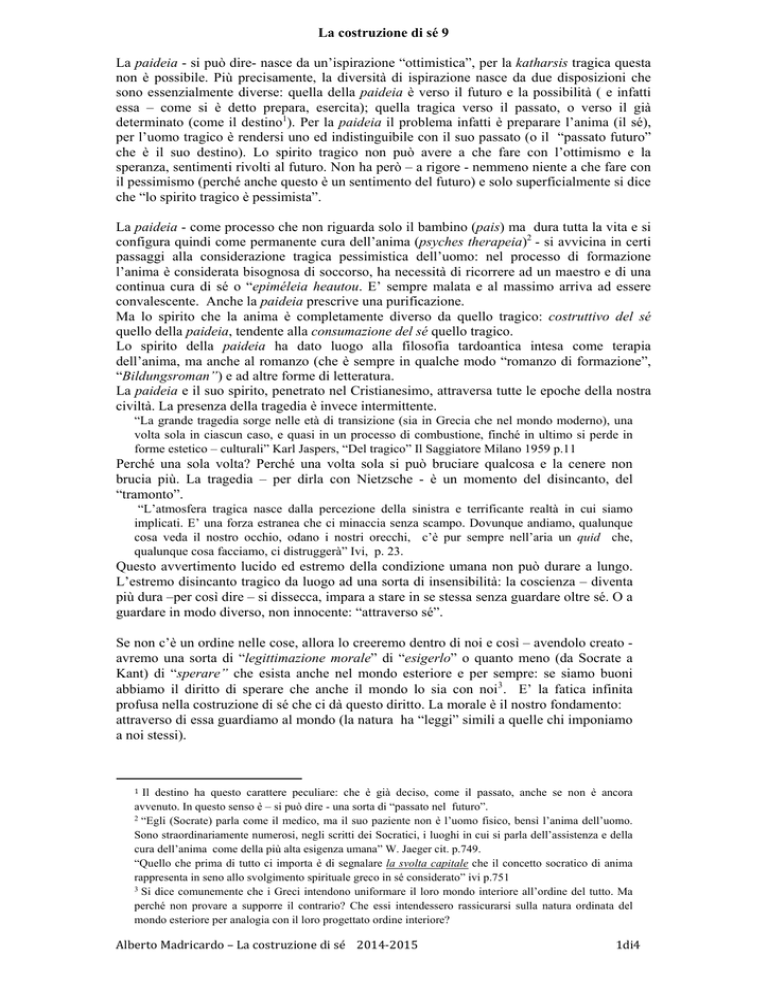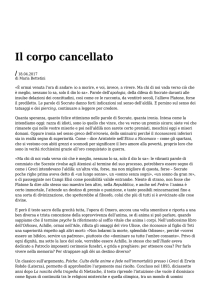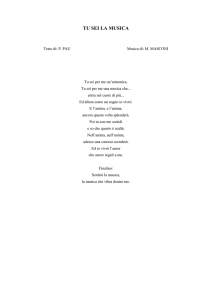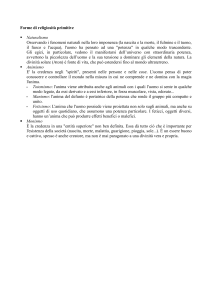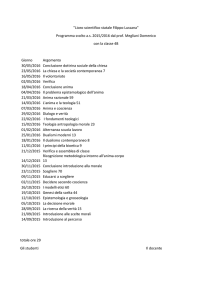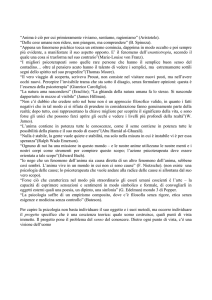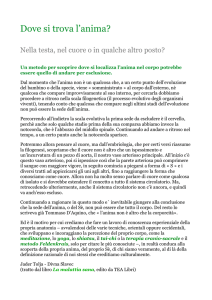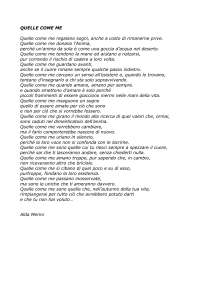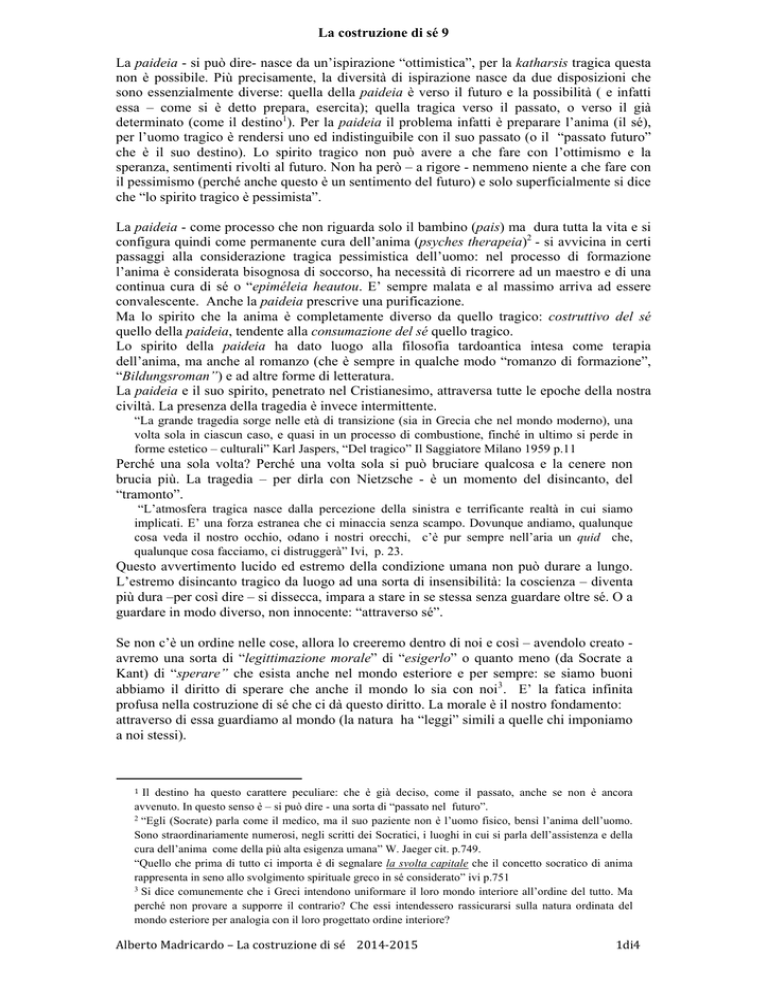
La costruzione di sé 9
La paideia - si può dire- nasce da un’ispirazione “ottimistica”, per la katharsis tragica questa
non è possibile. Più precisamente, la diversità di ispirazione nasce da due disposizioni che
sono essenzialmente diverse: quella della paideia è verso il futuro e la possibilità ( e infatti
essa – come si è detto prepara, esercita); quella tragica verso il passato, o verso il già
determinato (come il destino1). Per la paideia il problema infatti è preparare l’anima (il sé),
per l’uomo tragico è rendersi uno ed indistinguibile con il suo passato (o il “passato futuro”
che è il suo destino). Lo spirito tragico non può avere a che fare con l’ottimismo e la
speranza, sentimenti rivolti al futuro. Non ha però – a rigore - nemmeno niente a che fare con
il pessimismo (perché anche questo è un sentimento del futuro) e solo superficialmente si dice
che “lo spirito tragico è pessimista”.
La paideia - come processo che non riguarda solo il bambino (pais) ma dura tutta la vita e si
configura quindi come permanente cura dell’anima (psyches therapeia)2 - si avvicina in certi
passaggi alla considerazione tragica pessimistica dell’uomo: nel processo di formazione
l’anima è considerata bisognosa di soccorso, ha necessità di ricorrere ad un maestro e di una
continua cura di sé o “epiméleia heautou. E’ sempre malata e al massimo arriva ad essere
convalescente. Anche la paideia prescrive una purificazione.
Ma lo spirito che la anima è completamente diverso da quello tragico: costruttivo del sé
quello della paideia, tendente alla consumazione del sé quello tragico.
Lo spirito della paideia ha dato luogo alla filosofia tardoantica intesa come terapia
dell’anima, ma anche al romanzo (che è sempre in qualche modo “romanzo di formazione”,
“Bildungsroman”) e ad altre forme di letteratura.
La paideia e il suo spirito, penetrato nel Cristianesimo, attraversa tutte le epoche della nostra
civiltà. La presenza della tragedia è invece intermittente.
“La grande tragedia sorge nelle età di transizione (sia in Grecia che nel mondo moderno), una
volta sola in ciascun caso, e quasi in un processo di combustione, finché in ultimo si perde in
forme estetico – culturali” Karl Jaspers, “Del tragico” Il Saggiatore Milano 1959 p.11
Perché una sola volta? Perché una volta sola si può bruciare qualcosa e la cenere non
brucia più. La tragedia – per dirla con Nietzsche - è un momento del disincanto, del
“tramonto”.
“L’atmosfera tragica nasce dalla percezione della sinistra e terrificante realtà in cui siamo
implicati. E’ una forza estranea che ci minaccia senza scampo. Dovunque andiamo, qualunque
cosa veda il nostro occhio, odano i nostri orecchi, c’è pur sempre nell’aria un quid che,
qualunque cosa facciamo, ci distruggerà” Ivi, p. 23.
Questo avvertimento lucido ed estremo della condizione umana non può durare a lungo.
L’estremo disincanto tragico da luogo ad una sorta di insensibilità: la coscienza – diventa
più dura –per così dire – si dissecca, impara a stare in se stessa senza guardare oltre sé. O a
guardare in modo diverso, non innocente: “attraverso sé”.
Se non c’è un ordine nelle cose, allora lo creeremo dentro di noi e così – avendolo creato avremo una sorta di “legittimazione morale” di “esigerlo” o quanto meno (da Socrate a
Kant) di “sperare” che esista anche nel mondo esteriore e per sempre: se siamo buoni
abbiamo il diritto di sperare che anche il mondo lo sia con noi3 . E’ la fatica infinita
profusa nella costruzione di sé che ci dà questo diritto. La morale è il nostro fondamento:
attraverso di essa guardiamo al mondo (la natura ha “leggi” simili a quelle chi imponiamo
a noi stessi).
destino ha questo carattere peculiare: che è già deciso, come il passato, anche se non è ancora
avvenuto. In questo senso è – si può dire - una sorta di “passato nel futuro”. 2 “Egli (Socrate) parla come il medico, ma il suo paziente non è l’uomo fisico, bensì l’anima dell’uomo.
Sono straordinariamente numerosi, negli scritti dei Socratici, i luoghi in cui si parla dell’assistenza e della
cura dell’anima come della più alta esigenza umana” W. Jaeger cit. p.749.
“Quello che prima di tutto ci importa è di segnalare la svolta capitale che il concetto socratico di anima
rappresenta in seno allo svolgimento spirituale greco in sé considerato” ivi p.751
3 Si dice comunemente che i Greci intendono uniformare il loro mondo interiore all’ordine del tutto. Ma
perché non provare a supporre il contrario? Che essi intendessero rassicurarsi sulla natura ordinata del
mondo esteriore per analogia con il loro progettato ordine interiore? 1 Il
AlbertoMadricardo–Lacostruzionedisé2014‐20151di4
Ma è come se, raggiunto il massimo d’illuminazione delle cose, non se ne sopportasse la
luce: distolgo gli occhi dall’orrore del caos del mondo, verso il quale sono impotente e li
poso su me stesso, su cui invece posso operare. Oppure sostengo l’urto con la verità. La
realtà svelata dalle nebbie del mito – che per sua natura dice e nasconde (con questa
doppiezza si è consolato l’uomo arcaico) - è un colpo terribile, che travolge e spazza via
l’anima. Da questo spiazzamento radicale si avvia la catarsi.
Jaspers descrive così il “passaggio tragico” dal mito alla filosofia:
“Il mondo mitico resta il materiale della tragedia greca. La novità è che ora, nella coscienza
tragica, non regna più la pace, ma che l’interrogativo filosofico incalza. Le domande e le
risposte vengono calate in nuove rielaborazioni dei miti. Solo adesso i miti raggiungono la loro
maturità e profondità, ma, in qualunque forma si prestino, divengono instabili. Ogni poeta –
pensatore li trasforma, finché si consumano nell’alto processo di combustione di un
appassionato anelito alla verità (sotto forma di dialogo tra il poeta e la divinità) e non lasciano
più altro che le loro ceneri nelle immagini poetiche sempre deliziose, ma ormai prive di
impegno morale (…) Perché il mondo è così? Che cos’è l’uomo? Che cosa lo spinge? La colpa
e il fato che sono? Che sono gli ordinamenti della società umana e da dove provengono? Che
cosa sono gli dei?” (cit. p 16)
I poeti tragici dell’età classica (non quelli successivi) con le loro domande gettano per la
prima volta lo sguardo del logos sul mito, ed è come se le loro anime vedessero la
doppiezza di tutto. Ciò solo una volta si può vedere, prima che l’abitudine veli di nuovo i
loro occhi (l’abitudine vela tutto, anche l’orrore).
Ciò che precisamente sia questa catarsi, non risulta chiaro nemmeno in Aristotele. Ma in tutti i
casi è un evento che riguarda la più intima personalità umana. E’ un aprirsi del nostro spirito
all’essere, nato non solo dall’esperienza della contemplazione eterna, ma da una nostra diretta
partecipazione interna, una assimilazione del vero grazie alla purificazione da tutto ciò che fa
velo, che intorbida, che impaccia la nostra angusta e accecante visione del mondo. (Cit. p. 17)
Ma la catarsi descritta in questo modo non assomiglia forse troppo alla paideia? Il cui
risultato è cosi descritto:
“La conoscenza del Buono, che Socrate trova al fondo di tutte le cosiddette “virtù” umane,
singolarmente prese, non è un’operazione dell’intelletto, ma come Platone ben vide,
l’espressione, fattasi consapevole, di un “essere” intimo dell’uomo. Essa ha radice in uno strato
profondo dell’anima, dove l’essere penetrato dalla conoscenza e il possesso del conosciuto non
si possono scindere, ma sono essenzialmente uno” (Jaeger cit. p. 796)
Forse la differenza tra paideia e catarsi tragica sta nel carattere costruito della prima: si
giunge alla contemplazione del vero dopo una preparazione che si può sempre riprodurre.
La catarsi invece si può forse interpretare come azione dell’anima dopo l’urto del destino
che la ha spostata e quindi “posta su un’altra base”. La paideia si può pensare come
ricostruzione dello sguardo panoramico originario di Narciso che è andato perduto dopo la
caduta nella parzialità dello stare nel mondo, che si può avere senza uscire dai confini
dell’anima (essa - anche se si è sbilanciata verso altro e questo sia perciò diventato per lei
marginale - porta sempre dentro di sé il proprio centro). Nella anamnesis (il ricordo di sé)
(come dice Platone4) l’anima si ritrova ricentrandosi sulla sua base nella equidistanza da
tutto. La catarsi – al contrario – forse si può intendere come il formarsi di un nuovo
rapporto con il mondo, ma da un’altra base. Che non è un altro (secondo) rapporto come
quello creato dalla rammemorazione, (il ricordo ci presenta le cose più pallide, non come
“la prima volta” ecco perché il mondo della tarda antichità sarà un “mondo pallido”), ma trovandosi spostata nella sua base - vede il mondo di nuovo, ma per la prima volta.
4
Platone parla di anamnesi – di conoscenza come “reminiscenza dell’anima” - in tre dialoghi: Fedro,
Fedone, Menone. AlbertoMadricardo–Lacostruzionedisé2014‐20152di4
La costruzione di sé 10
Il mondo del mito non è un paradiso: è un mondo artificiale creato dall’uomo al fatto che
dispone del. E’ un guazzabuglio di favole, di trucchi, allusioni e sviamenti creato grazie al
linguaggio, di pratiche rituali. Alla base c’è l’ingenua (magica) identificazione delle parole
con le cose, per cui si ritiene che basti manipolare le prime per padroneggiare le seconde.
Tutto questo dispositivo di illusioni e autoinganni non ha alcuna efficacia sulla realtà di fatto,
ma ce l’ha sugli uomini, sui loro animi. Che importa che ciò avvenga per mezzo di incoerenze
e autoinganni? Passare attraverso la vita meno peggio possibile, non cercare ad ogni costo la
“verità”: questo importa. “Se la verità è terribile, aggiriamola”: così si comporta l’uomo
arcaico seguendo il suo istinto. Ma anche l’uomo “tardo”, che ha alle sue spalle l’esperienza
del rigore del logos. Egli usa la filosofia per barcamenarsi nella vita:
“E’ bene … oscurare il peggio bilanciandolo con il meglio. Quando i nostro occhi sono feriti da qualcosa
di troppo luminoso, li distogliamo e li riposiamo posandoli sui colori dei fiori e dell’erba”.
“Aristippo (…) bilanciando i lati peggiori della situazione con quelli migliori, sapeva risollevarsi e sentirsi
di nuovo leggero” Plutarco, “De tranquillitate animi” 469 A, B
“Come fanno i musicisti che attenuano sempre le note più basse con quelle più alte, si devono avvolgere
gli eventi più sfavorevoli con quelli positivi, facendo della nostra vita una mescolanza armoniosa e a noi
accogliente per noi (mígma emmelés kai oikeion autois). Ivi.
Che cosa manca ad entrambi, (all’uomo “arcaico” che vive nel mito e all’uomo
“tardo” che vive dopo l’avvento del logos?). L’ardore della conoscenza: il primo
non ce l’ha ancora, il secondo non l’ha più. La filosofia, per quest’ultimo, è
diventata una terapia, una tecnica di rassicurazione attraverso l’uso delle parole.
Che cosa hanno in comune? La fiducia nella funzione risolutiva della parola e nelle
pratiche rituali. E l’astuta abilità nell’usarle.
Per loro il problema non è tanto sapere come stanno le cose, ma manovrare le
situazioni secondo come conviene per trarre dalla vita il massimo beneficio, per
salvare il più possibile “la pelle” nel passaggio attraverso la vita.
Lo spirito tragico e il suo tramonto
Quello che accade ai Greci, ad un certo punto, è che si impongono una inusitata
fermezza. Il loro sguardo si fa fisso sulle cose. La persistenza è l’elemento essenziale
della memoria e della coscienza: il principio del sé. Si impongono di non cambiare
con il cambiamento, diventando “rossi” in ambiente rosso, “verdI” in ambiente verde, come
il camaleonte. Come uno scoglio immobile nella corrente del cangiare delle cose è il principio
di identità, la cui enunciazione è l’atto fondativo del logos. Ogni cosa è se stessa, “ancorata a
se stessa”. Noi stessi siamo obbligati ad essere ciò che siamo, ad esercitare l’attenzione
(prosoché) e il dominio (enkráteia) di noi stessi.
Gli uomini da tempo immemorabile si scrollano di dosso le loro angosce e si dimenticano
di se stessi ubriacandosi. L’ubriaco è l’uomo che non è più presente a se stesso, che fa
venere meno la sua attenzione (prosoché) e il controllo di sé. Perciò perde, come Noè
biblico5, la sua dignità.
E’ ciò che Socrate non ha mai fatto. Così Alcibiade lo descrive:
“Nelle baldorie lui solo sapeva godere fino in fondo e a bere – non che lo volesse, ma quando lo si forzava
– vinceva tutti; ma ciò che più meraviglia è che nessuno ha mai visto Socrate ubriaco”(Platone,
“Simposio” 220 a)
5
“Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. [21] Avendo bevuto il vino, si ubriacò e
giacque scoperto all'interno della sua tenda. [22] Cam, padre di Cànaan, vide il padre scoperto e raccontò la
cosa ai due fratelli che stavano fuori. [23] Allora Sem e Iafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle
spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto; avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre
scoperto. [24] Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore; [25] allora
disse: "Sia maledetto Cànaan! Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli!" (Genesi 9, 20-25).
AlbertoMadricardo–Lacostruzionedisé2014‐20153di4
Socrate è sempre presente a se stesso. Da dove viene questo impulso e questa forza? Forse
dalla fierezza, e dalla virtù militare (andreía) che impone di stare al proprio posto, di non
fuggire. E sempre Alcibiade, nella ritirata da una battaglia perduta dagli Ateniesi:
“Meritava davvero, o amici di vedere Socrate quando l’esercito si ritirava in rotta da Delio6
(….) mi pareva che camminasse come qui (in città, al sicuro da ogni pericolo n.d.r.),
Aristofane7, come tu dici “tutto fiero e sbirciando di traverso” e squadrava con calma amici e
nemici mostrando chiaro ad ognuno anche di lontano che se qualcuno avesse attaccato
quest’uomo, con grande forza si sarebbe difeso.” (ivi, 221b).
Socrate è sempre se stesso a prescindere dalle situazioni: la coerenza è la forza del logos.
Esso spinge la volontà a non farsi travolgere dalle cose, di avere la possibilità di non
vivere sempre impegnati ad affermare il proprio particolare esistere ma di fare esperienza
di essere come tale (l’esistere, l’esserci - dasein - è il “trauma dell’essere”, la caduta –
come dice Platone - a causa della quale l’essere perde la propria esperienza panoramica
totale di sé, ma si vive sempre confuso con la situazione che sta vivendo in ogni
momento).
Come in battaglia si deve restare fermi nella propria posizione, sia che si vinca che si
perda, così nella vita. Fino ad un certo punto gli uomini affidano il senso del loro esistere
alle favole divine che si tramandano e agli dei che ne sono i protagonisti, ma quando
imparano a restare coerenti ne scoprono le contraddizioni.
E allora l’uomo greco getta lo sguardo in queste contraddizioni e non arretra. E’ questa
rigidità di coerenza, questa mancanza di “flessibilità” - di astuzia – che gli fa penetrare
l’orrore della mancanza di senso del tutto. Ma lo spirito tragico non consiste solo in
questo: non è solo “sentimento del soggetto” (della sua fierezza), è anche ”sentimento
dell’oggetto”, della scoperta che egli ha fatto. In altri termini egli ne sopporta l’orrore in
virtù dell’averlo scoperto. Si può conoscere anche la cosa più tremenda, come il destino
(Moìra) la sua inesorabile necessità, se si è certi di averla conosciuta, di averla “stanata”
come si fa con una preda: il conoscerlo riscatta ciò che si conosce.
Quella particolare disposizione totale dell’animo al conoscere – tra altri significati - si
esprime nel termine gnóme (γνώμη, che viene da gignóskein: conoscere).
Sono annientato da ciò che vengo a conoscere, ma sono realizzato pienamente per il fatto
che lo conosco: disperato e felice insieme, perché sono entrato in contatto diretto con il
cuore nascosto delle cose.
Questo tipo di atteggiamento spirituale non può essere fatto durare nel tempo, dura un
istante come la luce del fulmine. Eraclito aveva detto che “di tutte le cose sta al timone (a
tutto dà l’orientamento) il fulmine8 (keraunós). Che cosa vuol dire? Forse che un lampo di
verità può come un colpo di timone dare la direzione a un’intera epoca. L’epoca così
avviata sarà orfana della tragedia, un’epoca di “non più e non ancora”.
Al servizio di questa verità una volta apparsa, nel tentativo di rammemorarla e allo stedso
tempo di prepararsi ad essa. Un’epoca di esercizio (áskesis): di ascesi, a ricordare e a
prepararsi insieme. Un’epoca di servizio (therápeia), al servizio e in preparazione
(paraskeué) a ciò che non è più e non ancora.
Quello che le manca è la forza trascinante della gnóme, della, che non è solo volontà di
conoscere ma anche richiamo che viene da ciò che deve essere conosciuto. La
preoccupazione dell’uomo “tardo” sarà perciò di “darsi la forza” (di esercitarsi). Ma ciò
che alcuni uomini hanno provato prima di noi non spetta di diritto anche a noi. È possibile
che noi ne siamo inesorabilmente esclusi.
“L’uomo è infelice perché è schiavo delle passioni, ossia perché desidera cose che gli possono sfuggire
(…) La felicità consiste nell’indipendenza, nella libertà, nell’autonomina, vale a dire nel ritorno
all’essenziale, a ciò che è veramente noi stessi” P. Hadot “Esercizi spirituali e filosofia antica”, Einaudi
Torino 2002 p.60.
Ma liberarsi dalle passioni permette di ritornare all’equanimità. La conoscenza come
ritorno ha la forza di ritornare. Dà la felicità (il sollievo) di aver chiuso il circolo e di
esserci ritrovati. Non è la sovrabbondanza che dà la disperazione per ciò che si conosce
riscattata dal fatto di conoscerlo.
6
La battaglia si svolse nel 424 a.C. tra Ateniesi e Beoti e fu perduta dagli Ateniesi.
Aristofane, il poeta comico, descrive Socrate nella commedia “Le nuvole”.
8 “Tà de pánta oiakízei keraunós” (Eraclito, Diels 64).
7
AlbertoMadricardo–Lacostruzionedisé2014‐20154di4